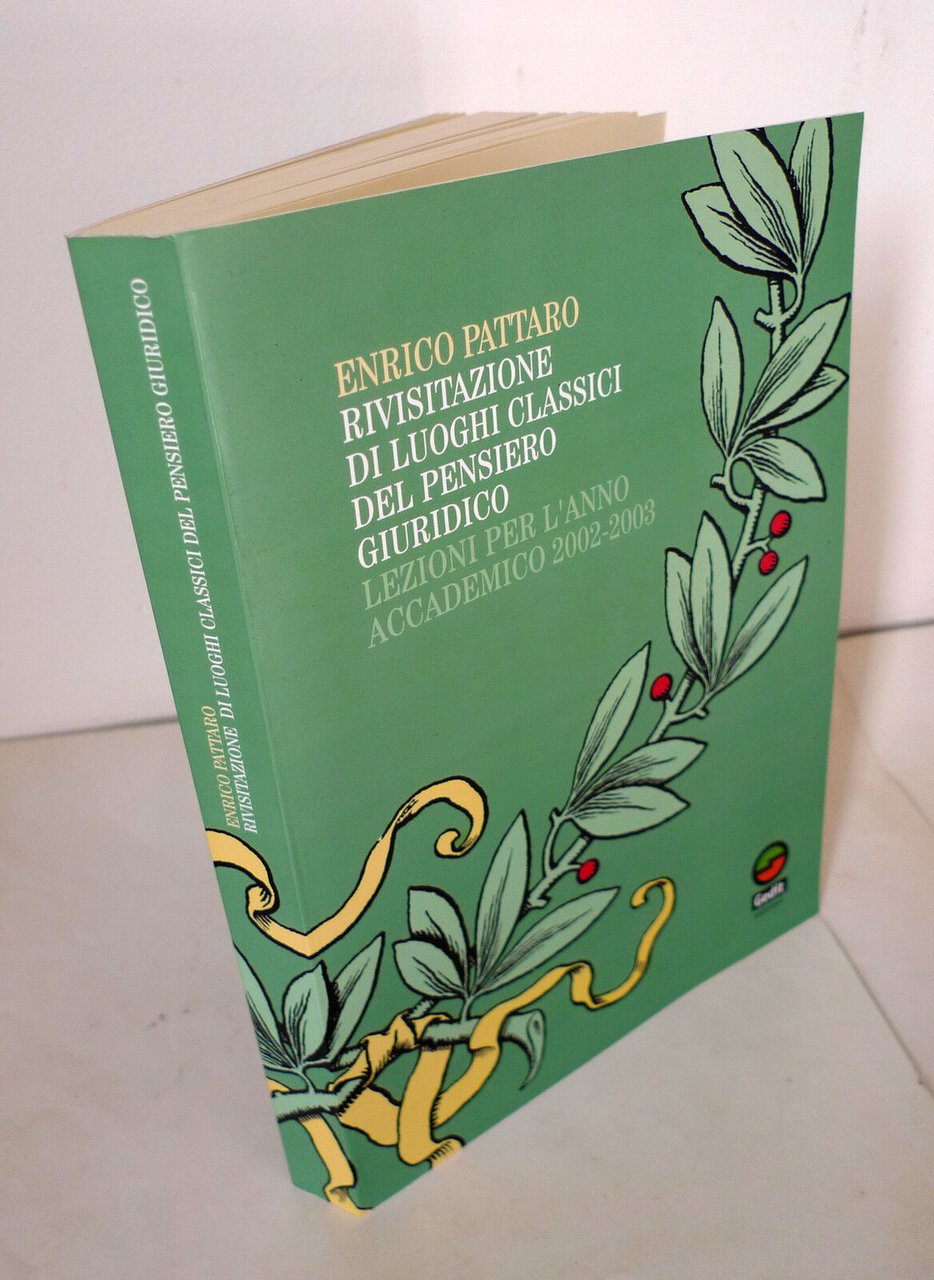
Periodici
Pattaro,RIVISITAZIONE DI LUOGHI CLASSICI DEL PENSIERO GIURIDICO[manuale,diritto
9,90 €
Modo Infoshop
(Bologna, Italia)
Le corrette spese di spedizione vengono calcolate una volta inserito l’indirizzo di spedizione durante la creazione dell’ordine. A discrezione del Venditore sono disponibili una o più modalità di consegna: Standard, Express, Economy, Ritiro in negozio.
Condizioni di spedizione della Libreria:
Per prodotti con prezzo superiore a 300€ è possibile richiedere un piano rateale a Maremagnum. È possibile effettuare il pagamento con Carta del Docente, 18App, Pubblica Amministrazione.
I tempi di evasione sono stimati in base ai tempi di spedizione della libreria e di consegna da parte del vettore. In caso di fermo doganale, si potrebbero verificare dei ritardi nella consegna. Gli eventuali oneri doganali sono a carico del destinatario.
Clicca per maggiori informazioniMetodi di Pagamento
- PayPal
- Carta di Credito
- Bonifico Bancario
-
-
Scopri come utilizzare
il tuo bonus Carta del Docente -
Scopri come utilizzare
il tuo bonus 18App
Dettagli
Descrizione
Enrico Pattaro,
RIVISITAZIONE DI LUOGHI CLASSICI
DEL PENSIERO GIURIDICO.
Lezioni per l'anno accademico 2002-2003.
Gedit Edizioni, Bologna 2002,
Prima edizione settembre 2002,
brossura, 24x17 cm., pp.381,
prezzo di copertina 42,00 euro,
ISBN: 88-88120-20-3
peso: g.680
COD: 2780
CONDIZIONI DEL LIBRO: nuovo
Sommario
Parte Prima IL DIRITTO
Capitolo Primo Aspetti della normatività giuridica 17
1.1 Diritto oggettivo e diritto soggettivo 17
1.2 Essere e dover essere 19
Capitolo Secondo I caratteri differenziali del diritto 23
2.1 Nozione 23
2.2 Bilateralità. Il rapporto giuridico. Fatto, atto
e negozio giuridico 23
2.3 Imperatività 28
2.4 Astrattezza 34
2.5 Generalità 36
2.6 Coercibilità 38
2.7 Certezza 44
Capitolo Terzo Le fonti del diritto 47
3.1 Ambiguità terminologiche 47
3.2 Fonti di validità 48
3.3 Fonti di cognizione 50
3.4 Fonti di produzione 51
3.4.1 Considerazioni preliminari 51
3.4.2 Fonti formali di produzione del diritto 53
3.4.2.1 La legge 53
3.4.2.2 La giurisprudenza 57
3.4.3 Fonti informali di produzione del diritto.
La consuetudine 65
Parte Seconda IL LAVORO DEL GIURISTA
Capitolo Quarto Linguaggio e interpretazione del diritto 75
4.1 L'uso sintomatico del linguaggio e il suo ef-
fetto illativo nella comunicazione 75
4.2 L'uso rappresentativo del linguaggio e il suo
effetto semantico nella comunicazione 77
4.3 L'uso dichiarativo del linguaggio e i suoi ef-
fetti semantico e illativo nella comunicazione 79
4.4 L'uso direttivo del linguaggio e i suoi effetti
illativo, semantico e conativo nella comunica-
zione 81
4.5 Significante e significato (ambiguità e univo-
cità); riferimento e referente (concretezza dei
referenti, astrattezza e vaghezza dei significa-
ti che vi si riferiscono); lessico e grammatica 84
4.6 L'interpretazione dei testi giuridici alla luce
di alcune disposizioni del codice civile e del
concetto di “significato” 88
4.7 Interpretazione come attività e interpretazio-
ne come risultato 95
4.8 Tipi di interpretazione 96
4.8.1 L'interpretazione a seconda degli interpreti:
autentica, giurisprudenziale, dottrinale 96
4.8.2 L'interpretazione a seconda dei modi inter-
pretativi: letterale, sistematica, logica 96
4.8.3 L'interpretazione a seconda dei risultati in-
terpretativi: dichiarativa, restrittiva, esten-
siva 98
Capitolo Quinto Integrazione del diritto 101
5.1 Incompletezza degli ordinamenti giuridici.
Come colmare le lacune 101
5.2 L'analogia legis 106
5.3 L'argumentum a contrario 108
5.4 L'argumentum a fortiori 108
5.5 L'argomento apagogico 109
5.6 L'analogia iuris 111
Capitolo Sesto Rendere coerente il diritto 117
6.1 Incoerenza degli ordinamenti giuridici. Come
risolvere le antinomie 117
6.2 L'appartenenza all'ordinamento giuridico 117
6.3 II criterio gerarchico 118
6.4 II criterio cronologico 119
6.5 II criterio di specialità 120
6.6 Metacriteri 120
Capitolo Settimo Sulla natura del lavoro del giurista
e sulla sua funzione rispetto al diritto 121
7.1 Se la dottrina giuridica sia scienza 121
7.2 Se la dottrina giuridica sia fonte del diritto 127
7.3 Elaborazione ed interpretazione di testi vs
emanazione di testi. Attività di governo me-
diante emanazione di testi: legislazione; am-
ministrazione, autonomia privata. Attività di
controllo mediante emanazione di testi: giu-
risdizione 129
Parte Terza MOMENTI DI STORIA DELLA FILOSOFIA
DEL DIRITTO
Capitolo Ottavo II giusnaturalismo 139
8.1 Diritto naturale versus diritto positivo 139
8.2 II diritto naturale come volontà 140
8.3 II diritto naturale in senso biologico 142
8.4 II diritto naturale come ragione. La sistema-
zione tomistica: lex aeterna, lex naturalis,
lex humana, lex divina 144
8.5 II diritto positivo come volontà produttiva di
norme 147
8.6 I codici giusnaturalistici 151
Capitolo Nono II positivismo giuridico tedesco
da Savigny a Kelsen 155
9.1 II formalismo dopo il primo Savigny, nella
pandettistica e nella giurisprudenza dei con-
cetti fino all'allgemeine Rechtslehre 155
9.2 Volontarismo, dualismo e statualismo nella
concezione del diritto positivo del positivi-
smo giuridico tedesco ottocentesco 160
9.3 Kelsen e la dottrina pura del diritto 165
9.3.1 Un diritto separato dalla morale e dalla na-
tura 165
9.3.2 II dover essere come categoria 166
9.3.3 La coazione come contenuto del diritto 170
9.3.4 II diritto come tecnica di motivazione indi-
retta 173
9.3.5 II volere produttivo di dover essere. La va-
lidità come oggettività del dover essere 175
9.3.6 Ordinamenti statici e ordinamenti dinamici 180
9.3.7 La norma fondamentale presupposta 123
9.3.8 Validità ed efficacia 189
9.3.9 Validità e obbligatorietà 193
Capitolo Decimo Dall’empirismo dell'Analytical Jurispru-
dence al realismo giuridico americano 197
10.1 Volontarismo empiristico 197
10.2 La giurisprudenza analitica inglese 198
10.3 Critica del volontarismo empiristico 199
10.4 II realismo giuridico americano 208
Capitolo Undicesimo II realismo “normativistico” della scuola
di Uppsala e di H.L.A. Hart 209
11.1 Il realismo giuridico scandinavo 209
11.2 Hart sulla scia di Hagerstrom 217
Parte Quarta LA PROSPETTIVA DI CHI SCRIVE
Capitolo Dodicesimo Regole e principi, sistemi e ordinamenti:
una vecchia storia poco nota 229
12.1 Obiettivo del presente capitolo 229
12.1.1 Sinossi preliminare 22 9
12.1.2 Da Reichenbach a Pascal ad Aristotele 232
12.2. I principi nei sistemi assiomatico-deduttivi 237
12.2.1 Ragione scientifica (forte) e ragione opi-
nante-deliberante (debole). La scienza
come geometria: Aristotele, Euclide e i
principi primi 237
12.2.2 Contesto della scoperta: conoscenza dei
principi in scienza 240
12.2.3 Dal contesto della scoperta al contesto
della giustificazione: Aristotele come
Platone 241
12.2.4 Conclusioni sui principi della scienza in
Aristotele 242
12.3 I principi negli ordinamenti di deliberazioni
(codici, leggi, regolamenti, ecc.) 244
12.3.1 I principi dell'agire in Aristotele. L'opi-
nione, il ragionamento dialettico 244
12.3.2 La prudenza in rapporto ai principi del-
l’agire 246
12.3.3 I principi tra ragione e ragionevolezza 249
12.4 La recezione dei principi in diritto 252
12.4.1 Nella dottrina giuridica, in filosofia del
diritto, nella teoria generale del diritto,
nella giurisprudenza e nella legislazione.
Le “regulae” come principi 252
12.4.2 Definitiones, regulae e principi in dirit-
to romano 254
12.4.3 La tradizione della scienza giuridica ro-
mana in diritto comune 260
12.4.4 Ragion teoretica e ragion pratica: ragio-
ne forte e ragione debole 265
12.4.5 I principi di ragione in Tommaso dA-
quino 271
12.5 Dalla ragione all’autorità. La codificazione
dei principi 280
12.5.1 Cenni preliminari 280
12.5.2 Ragione e autorità, filosofia e storia,
giurisprudenza, arte in Vico 280
12.5.3 Verità, Certezza, Ratio, Probabilità, Ve-
risimiglianza in Vico 281
12.5.4 La ragione debole come autorità 282
12.5.5 Autorità in senso forte e autorità in sen-
so debole 283
12.5.6 La recezione dei principi della ragione
forte e dei principi della ragione debole
nelle codificazioni: autorità in senso for-
te 284
Capitolo Tredicesimo Realtà culturale delle attività e delle pro-
duzioni umane. Dall’unità sistematica del
molteplice alla sistematica giuridica. Tre
concetti chiave: “fattispecie astratta”,
“validità” e “competenza” 287
13.1 Monismo ontologico e realtà culturali 287
13.2 Realtà culturale del diritto 291
13.3 II reperimento dei testi giuridici e la siste-
matica giuridica 294
13.4 L'unità sistematica del molteplice 299
13.5 II metodo dialettico-divisivo e la sistematica
giuridica 301
13.6 La synagoghe quale scoperta della base del
sistema mediante astrazione, analisi e defi-
nizione 304
13.7 Le forme ideali e le loro istanze attuali: le
fattispecie astratte come fact-types costituti-
vi della possibilità di fattispecie concrete o
fact-tokens. L'equivoco delle regole costitu-
tive 305
13.8 "Validità” e “competenza". Granularità e or-
dine nelle fattispecie astratte e nelle fatti-
specie concrete 309
Capitolo Quattordicesimo II comportamento umano e le norme 315
14.1 Requisiti, modelli e moventi dell’agire.
L'usus agendi 315
14.2 I moventi del comportamento come cre-
denze: bisogni, interessi, valori e norme.
Definizione di “credenza” 317
14.3 Norme, consuetudini e direttive 320
14.4 L'esistenza di una norma. Occorre almeno
un credente (dossia) 322
14.5 II contenuto delle norme: fattispecie astrat-
te complesse. Importanza cruciale dell’in-
sieme delle circostanze condizionante.
Norme penali e norme di competenza 323
14.6 II riferimento di una norma. Soggetti pas-
sivi (deontia) e soggetti attivi (exousia) 327
14.7 Circa la deontia: ubbidienza e disubbidien-
za alle norme, soggetti passivi praticanti e
soggetti passivi non praticanti 329
14.8 II vigore di una norma (nomia): soggetti
passivi credenti. La mancanza di vigore di
una norma (anomia): soggetti passivi non
credenti 329
14.9 Circa il vigore (nomia): efficacia e ineffica-
cia di una norma, soggetti passivi credenti
osservanti e soggetti passivi credenti de-
vianti 330
14.10 In caso di mancanza di vigore (anomia),
una norma è o ubbidita (conformismo dei
soggetti passivi non credenti) o disubbidita
(non-conformismo dei soggetti passivi non
credenti), ma non può essere efficace o
inefficace 332
Capitolo Quindicesimo Una società retta da norme 335
15.1 Individuo e società 335
15.2 Originaria assimilazione di norme dall’am-
biente sociale 336
15.3 Moltiplicazione delle norme originariamen-
te assimilate dall'ambiente sociale 337
15.3.1 II moltiplicatore è dato dal numero di
fattispecie concrete che realizzano vali-
damente la fattispecie astratta dell’insie-
me delle circostanze condizionante con-
templato nelle norme originarie 337
15.3.2 Sussunzione di fattispecie concrete vali-
de nell’insieme delle circostanze condi-
zionante e deduzione di nuove norme
dal modello di azione condizionato. A
partire da norme di condotta 338
15.3.3 Sussunzione di fattispecie concrete vali-
de nell’insieme delle circostanze condi-
zionante e deduzione di nuove norme
dal modello di azione condizionato. A
partire da norme di competenza 344
15.4 II gioco sociale delle norme: le parti in gio-
co, il gioco delle parti 346
15.5 II controllo sociale sui creduti soggetti passi-
vi: censura preventiva e repressiva. La dike-
dossia 349
15.6 II controllo sociale sui credenti: ortodossia,
paradossia, eterodossia, eresia, cattolodos-
sia. Altri significativi e altro generalizzato 351
Capitolo Sedicesimo Come usare il linguaggio per orientare
il comportamento altrui 355
16.1 II potere: minacce e promesse. L’interesse ad
evitare un castigo (sanzione punitiva) o a
conseguire un premio (sanzione premiale) 355
16.2 Influenza circa i bisogni, gli interessi e i va-
lori 356
16.3 Influenza circa le norme 357
16.4 Suggestione e carisma 358
16.5 Produrre norme con parole (o con colori) 361
16.6 Le norme nel diritto 362
16.6.1 Norme di competenza istitutive di auto-
rità 362
16.6.2 Validità di emanazione di testi e norma-
tività di testi validamente emanati 363
16.6.3 Diritto valido (law in books,), diritto in
vigore (law in minds,), diritto applicato
(law in action) 367
16.7 II diritto come interferenza nel comporta-
mento altrui 369
16.7.1 Diritto e morale 369
16.7.2 Diritto e forza 371
16.7.3 II diritto come dominio (Herrschaft) 375
16.7.4 Chi decide qual è il diritto 377

