CI-131 pagine. Brossura. Introduzione in italiano, testo latino. Commento dell'editore: Il presente volume raccoglie i sermoni superstiti di Gioacchino da Fiore, parte di una predicazione interna al chiostro che fu certamente più intensa. I sermoni giunti fino a noi, testimoniati principalmente dall'autorevole ms. Padova, Biblioteca Antoniana, 322, ci sono tramandati in due raccolte molto diverse. La prima, che abbiamo intitolato Sermones et capitula de lettera et spiritu, attesta, in una forma estremamente abbozzata, un fenomeno ben diffuso nella pratica omiletica medievale, ossia la raccolta di un gruppo di sermoni accomunati da una medesima tematica, che l'autore (o i suoi discepoli) raccoglievano insieme, a formare un trattato unitario. Partendo dall'occasione liturgica del commento alla domenica di settuagesima, il testo di Gioacchino si ampia in misura notevole per riflettere teologicamente sul significato simbolico della liturgia (in particolare della liturgia dei tempi precedenti la Pasqua). Il procedere delle argomentazioni si imposta come dibattito fittizio con l'ermeneutica ebraica: essa si ferma al significato della lettera, incapace di procedere oltre e di giungere al significato spirituale. Immagine pregnante del limite dell'ermeneutica ebraica è quella del biblico velo posto sul volto di Mosè: gli occhi del popolo ebraico sono ancora velati, incapaci di cogliere lo spirito delle Scritture. A partire poi dall'interpretazione del passo di Isaia relativo al dies irae, Gioacchino giunge a riflettere sul molteplice significato simbolico delle due città, Gerusalemme e Babilonia, anche in stretta connessione con gli avvenimenti politici di quel preciso torno di anni: siamo probabilmente nel 1187, nel momento in cui le relazioni tra il pontefice Urbano III e Federico Barbarossa si fecero tesissime, fino alla minaccia di un nuovo scisma. La riflessione ecclesiologica sui significati di Gerusalemme e Babilonia ha poi portato probabilmente a inserire tra questi testi anche uno scritto di argomento più specifico, che attraverso le tipologie femminili di Agar, Sara, Elisabetta e Maria affronta la tematica della successione, nel corso della storia, di tre diverse forme di ecclesia. Come l'ecclesia rappresentata da Agar è stata superata da quella rappresentata da Sara ed Elisabetta, così l'ecclesia rappresentata da Elisabetta verrà superata, nei già vicini tempi escatologici, dall'ecclesia rappresentata da Maria. La seconda raccolta presenta sei sermoni liturgici (e circolo anni), relativi alle principali festività o occasioni dell'anno (Natale, mercoledì delle ceneri, prima domenica di quaresima, domenica delle palme, Pasqua, natività di Giovanni Battista). Già editi precedentemente da Ernesto Buonaiuti in appendice al De articulis fidei, questi sermoni liturgici ci presentano l'immagine di Gioacchino quale abate che, con un linguaggio più semplice rispetto alle grandi opere, parla ai suoi monaci, li esorta alla penitenza, alle opere di misericordia e all'umiltà, pur non tralasciando mai una minima riflessione di ordine teologico. All'importante testimone costituito dall'antologia gioachimita dell'Antoniano 322, che ci offre il numero maggiore di testi e insieme i più ampi, la tradizione manoscritta dei sermoni di Gioacchino comprende anche il ms. Città del Vaticano, Biblioteca Apostolica Vaticana, Vat. Lat. 4860, che riporta la versione sintetica di due dei testi compresi nei Sermones et capitula de lettera et spiritu (versione sintetica pubblicata anche a sé, nell'Appendice) e il ms. Dresden, Sächsische Landesbibliothek A. 121, in cui sono raccolti frammenti di due dei sermoni liturgici.
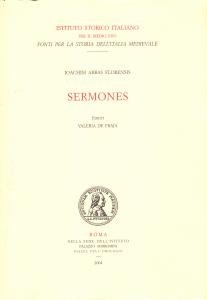
Scopri come utilizzare
Scopri come utilizzare

